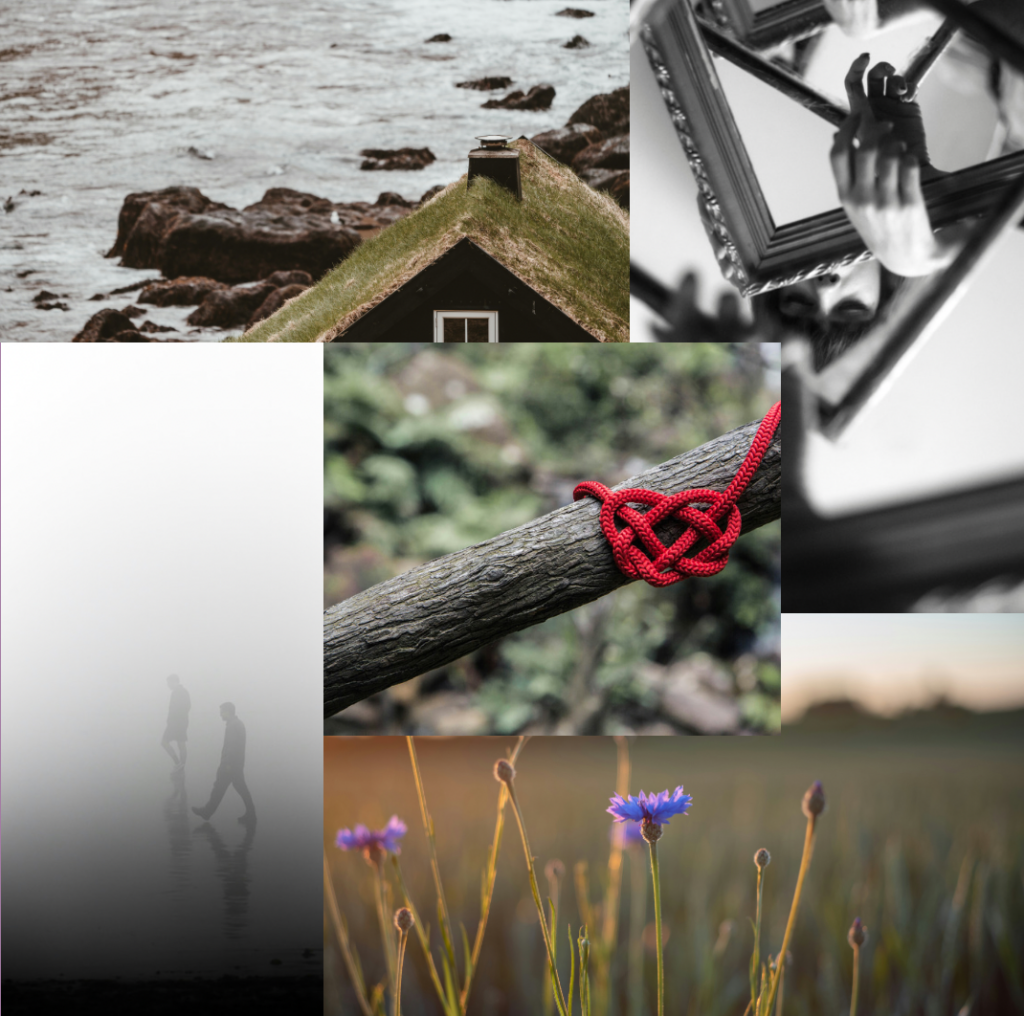Il falso è l’unica cosa che sono in grado di giurare, l’ho imparato da bambina.
E dire che mamma si è sbattuta un sacco per insegnarmi a non dire le bugie, si è sforzata proprio tanto per assicurarsi che imparassi a dire sempre solo e soltanto le cose come stanno. Si è sforzata tanto che spesso, dopo lo sforzo, le veniva l’emicrania, un’emicrania soffocante diceva lei, e spariva in camera da letto, al buio. Ogni volta mi diceva che non era colpa mia, ma dello sforzo di tenere lontane le bugie. «Giura», le rispondevo io, ma lei rimaneva in silenzio e non giurava. Mi accarezzava la faccia dalla fronte scendendo verso il naso mi si chiudevano gli occhi e lei si ritirava nel buio.
Ci ho ripensato decine di volte e sono certa che non potesse essere altro che colpa mia.
Mi ricordo di quella volta che mamma si sforzò affinché io fossi in grado di dire solo e soltanto le cose come stavano, pur di non dire una bugia alla nonna. Era pomeriggio, faceva caldo ma non troppo e c’era quel vento tiepido che spira dal mare e fa strofinare le tapparelle di plastica dentro le guide metalliche che stanno sui tre lati delle finestre. Quella volta papà era uscito presto, poco dopo pranzo.
«Esci presto?»
«Sì, ho da fare in studio».
«Torni a cena?»
«No, non vedi che ho il borsone?»
«Vedo che hai il borsone ma torni per la cena?»
«No! Ho il calcetto, non torno per cena». Parlò, ma con me. «Dove ha la testa tua madre?» Mi salutò pure e non sorrise, né a me né tantomeno a lei.
«Torna presto», ma tanto la porta dell’ascensore già stava cigolando.
Il rubinetto rimase aperto per tutto il tempo e, per tutto il tempo, mamma parlò e ascoltò tenendo le mani sotto il getto fitto dell’acqua bollente. Restò a guardarsi la macchia rosata che si allargava sulla pelle bagnata, ma non fece niente. E allora mi avvicinai io al lavandino, chiusi in fretta il rubinetto e le coprii le mani con uno strofinaccio da cucina, morbido.
«Faccio io, lascia lascia». E mi accarezzò la faccia con tutto il palmo aperto, bagnato, facendolo scorrere dalla fronte scendendo verso il naso. «Ma dove ho la testa?» E si mise a sedere, con le mani nascoste dalla spugna umida, sulla sedia pieghevole che stava sotto la finestra. La cucina rimase com’era, in disordine – succedeva spesso, perciò predissi che, al suo ritorno, papà avrebbe messo gli occhi nella stanza, avrebbe sbuffato ripetutamente, sarebbe andato dritto verso la credenza in sala da pranzo, avrebbe spalancato le ante e avrebbe controllato la boccetta girandosi verso il lampadario e inclinandola in aria.
Presi i miei quaderni e, nella cucina in disordine, mi sistemai sul lato corto del tavolo, vicino ai coperchi di acciaio lasciati a sgocciolare, di fronte a mamma, che si guardava le mani, nascoste. Un pezzo di pomeriggio trascorse, non so dire quanto, ma solo che avevo finito i compiti e che avevo tra le mani il telecomando e che la tv strillava la sigla di Lady Oscar, quando il telefono, dal corridoio, si sovrappose alla televisione.
Contai quattro squilli, continuando a guardare mamma che restava in silenzio e si guardava le mani. Solo quando saltai giù dalla sedia e corsi in corridoio, mamma si mosse.
«Di’ che non posso venire al telefono, chiunque sia. Ho le mani nella terra», disse forte. Dal corridoio attraverso la porta riuscii a vederla: stava in piedi davanti al tavolo della cucina, con le mani infilate e ferme nella terra che riempiva il vaso di gerani che tenevamo sulla finestra -lo aveva appoggiato vicino ai coperchi, proprio sopra i miei quaderni.
Mi schiacciai la cornetta contro l’orecchio e non feci altro che dire solo e soltanto come stavano le cose, che non poteva venire al telefono, che aveva le mani nella terra. «Sì, nonna, le dico di chiamarti quando ha finito», aggiunsi fissando la rotella del telefono e riappoggiai la cornetta sull’apparecchio. Quando dal corridoio cercai di nuovo con lo sguardo mamma, di nuovo lei non si fece trovare.
Tornata in cucina la vidi che si era già riseduta e si guardava di nuovo le mani, girava con due dita la fede intorno al suo anulare sinistro, sempre più magro. Le mani erano sporche di terra, la stessa dalla quale aveva sfilato le dita e che aveva seminato sul tavolo e sul cuscino di una sedia e sul pavimento e che, ora, le stava sporcando pure la gonna. Raccolsi lo strofinaccio che stava sul pavimento davanti ai suoi piedi e lo bagnai sotto l’acqua tiepida, tornai da mamma e feci per pulirle le mani. «Lascia lascia, faccio io», mi disse senza guardarmi e si strofinò le mani sulla gonna. Si alzò, facendo leva con le mani sui braccioli della sdraio, che rimasero umidi e sporchi. «Te ne vai?», chiesi alla sua schiena.
«Sì, è l’emicrania».
«Hai mangiato?» Mi svegliò la mano di papà che mi scuoteva la spalla.
Spensi il televisore.
«Che è successo qua dentro?»
Chiusi i quaderni, che stavano ancora sul tavolo con i coperchi e la pianta e la terra, e li misi nello zaino.
«E pulisciti la faccia».
Mi strofinai una guancia con lo strofinaccio, quello morbido, per togliere la saliva che mi era colata dalla bocca.
«Tua madre è a letto, vestita, e qua c’è il solito casino. Anzi no, di più».
Mi misi a raccogliere i coperchi e la terra mentre lui camminava verso la credenza.
«Non fare rumore, vieni qua».
Lo raggiunsi, coi coperchi in mano e la bocca stretta.
«Ha preso le gocce?»
La bocca mi si aprì un poco, muta.
«Ti ho chiesto solo questo, a papà. Di guardarla quando non ci sono. Allora?»
«L’ho guardata».
«E le gocce le ha prese?» – inclinò la boccetta per aria, tenendola per il tappo tra il pollice e l’indice, la scosse una volta e poi di nuovo.
Io mi misi a pensare al liquido opaco che faceva le onde dentro la boccetta scura. Per un pelo non mi scappò da ridere e mi vergognai. Guardai il pensile aperto alle spalle di papà, mi misi a contare le scatolette di tonno. Il mio stomaco borbottò. « Me ne apri una?» e indicai il mobile aperto alle sue spalle..
Papà si girò, ma dalla parte opposta, verso il lampadario e insisté a guardare il vetro bruno contro la luce bianca. «Tu l’hai vista?» E sbuffò.
Feci per rispondergli, il fiato prese la rincorsa e le spalle mi si alzarono. Muta.
«Devi starci attenta, capito? Io posso contare solo su di te».
Le mie spalle caddero e pure un coperchio, secco.
«Allora, le ha prese, vero?»
«Mh» e guardai il coperchio.
«Giura!»
Io non risposi, lui mi credette.
Giugno mi piaceva per le giornate lunghe e per le fughe al porto, a fare i tuffi a bomba e le gare a chi resta sott’acqua più a lungo. Delle femmine, io ero quella coi polmoni più grandi e ne andavo fiera perché avevo pure l’asma e con l’asma non è da tutti stare sotto così tanto, mi diceva papà quando mi cronometrava nella vasca da bagno.
Quel giorno di giugno, quando tornai a casa dal porto, prima ancora che facessi la doccia, papà mi portò in sala da pranzo. «Facciamo un discorso». Aprì la credenza, prese la bottiglietta opaca e me la mise tra le mani. «Vedi se riesci ad aprirla».
Io provai a ruotare il tappo nero ma mi sembrò incollato. Feci per restituirgli la bottiglietta, mentre le mie spalle si alzavano.
«Devi spingere sul tappo e ruotare, contemporaneamente».
Le spalle caddero e io obbedii. La boccetta si aprì subito, al primo colpo. Mi sentii fiera, come una femmina con l’asma che sta sott’acqua più dei maschi.
«Sapevo che ne eri capace». Papà sorrise. «D’ora in poi, visto che non vai a scuola, conto su di te per le gocce di mamma».
«Che?», la bocca mi si allargò e riuscii solo a pensare che non sarei più potuta scappare al porto tutte le volte che volevo.
«Ne devi contare venti, mi raccomando, giuste giuste. Gliele metti in un bicchiere d’acqua, mi raccomando, poca. E guardi, mi raccomando, bene, che lei le prenda tutte».
«Mh». La bocca mi si strinse ma papà non la vide. Era già con tutti e due i piedi fuori dalla stanza.
Quella mattina mamma proprio non veniva avanti, come avrebbe detto zia Bice, che viveva da tanto tempo al nord. Era lunedì, papà era andato a lavorare e come al solito mi aveva svegliata presto perché mi lavassi e vestissi e, guardassi mamma.
Mancava poco alle undici e morivo dalla voglia di andare al porto a fare i tuffi a bomba, speravo che mamma si alzasse, che fosse di buon umore almeno un po’, abbastanza da venire con me sugli scogli a contare i secondi che sapevo stare sott’acqua. Andai in camera da letto e alzai appena un po’ le tapparelle, che entrasse qualche striscia di luce. La trovai sveglia.
«Andiamo al porto?»
«Dove sono le gocce, a mamma?»
Le dissi che erano in cucina, dove mi aveva detto di tenerle papà, che avrei preparato la colazione e poi gliele avrei date, come aveva detto papà. Mi rispose di dargliele prima della colazione, che non riusciva ad alzarsi altrimenti. Uscii dalla camera e tornai poco dopo, con un bicchiere d’acqua, poca, e le gocce.
Mamma si mise a sedere, ma ancora tutta dentro il letto. Prese il bicchiere con una mano mentre io svitavo il tappo nero della boccetta, premendo forte e ruotando.
«Ti sei fatta grande proprio». Sorrise, ma io non feci in tempo a vederla.
«Dieci. Undici. Dodi…»
«Faccio io, lascia. Lascia». Mi prese la mano in un modo che pareva una carezza – e non me la ricordavo – e mi tolse la boccetta. «Tu fammi un regalo, prepara il caffè».
«Con la cremina?»
«Sì, con la cremina».
Uscii dalla stanza. Tornai dopo poco, l’odore del caffè quasi non si sentiva più. «Ma’, si raffredda. Vieni?»
Si era distesa di nuovo e teneva gli occhi chiusi.
Le scossi un braccio.
«Cinque minuti, a mamma». Aprì gli occhi e li richiuse subito, con un sospiro.
Io tornai in cucina, non versai il caffè ma assaggiai la cremina. La assaggiai così tante volte che la finii tutta. Toccai la caffettiera, che si era raffreddata bene. Versai tutto il caffè giù nel buco del lavandino. Quando cominciò il telegiornale del Due, decisi di andare di nuovo a chiamare mamma.
Girai la rotella del telefono tutte le volte che serviva a comporre il numero dello studio di papà, tenendo la cornetta schiacciata contro la faccia.
«Mamma non si è alzata».
«Dorme?»
«Ha gli occhi chiusi».
«Vai a chiamarla».
«Mamma!», gridai. E la spinsi tutta, forte più che potei. Tornai in corridoio, ripresi la cornetta: «Non si sveglia. Vieni, non si sveglia».
«Le hai dato le gocce?»
«Sì».
«Venti, giuste giuste?»
«Vieni, papà». La faccia mi si bagnò tutta, a cominciare dagli occhi.
«Venti, giura!», insisté papà. Presi a calci il portaombrelli, forte.
«Mh». Di nuovo presi a calci il portaombrelli, più forte, tanto nessuno mi vedeva… «Vieni papà. Sbrigati!». Gridai.
Mi succede spesso di sognarla mia madre addormentata in quella scatola di legno così tanto più grande di lei, in cui l’ho guardata per l’ultima volta. Sogno che apre gli occhi e pure lei mi guarda. Sorride, abbastanza a lungo da lasciarsi vedere, allunga un braccio verso il mio viso e mi accarezza la faccia col palmo aperto, dalla fronte fin giù sopra la bocca. «Non è colpa tua», dice mentre lo fa. «Giura?», le chiedo io ad occhi chiusi e quando li apro lei non si fa trovare.