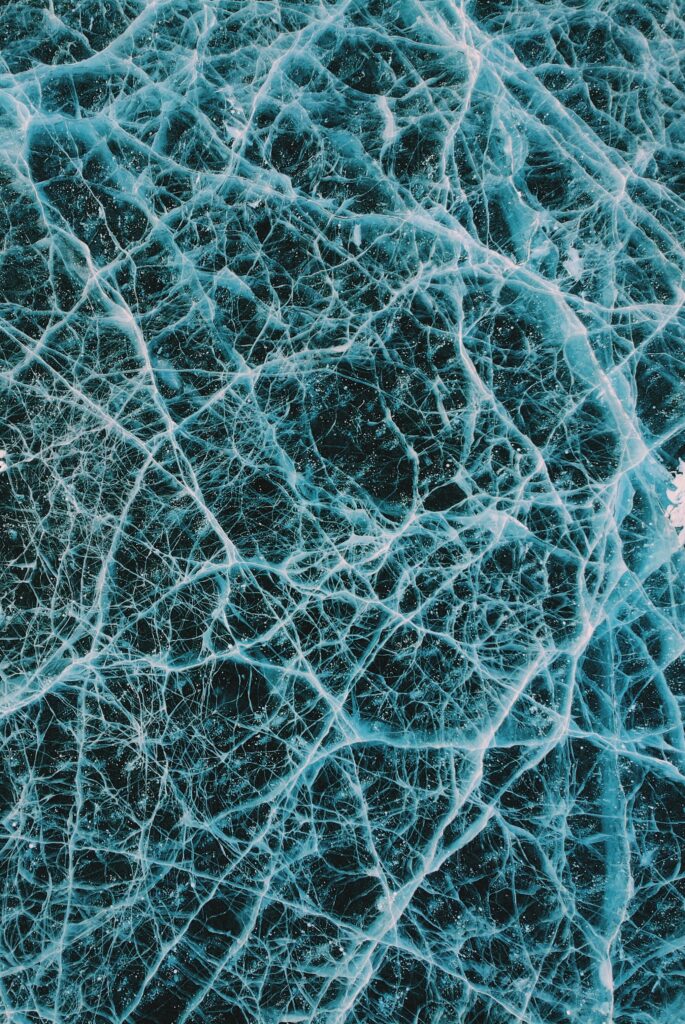Da molti anni ho l’abitudine – dormo davvero poco la notte – di arrivare in ufficio all’alba. Ho le chiavi di una porticina sul retro del palazzo dell’università. L’ufficio è all’ultimo piano, alla stessa altezza della chioma di un pino che mi blocca la visione del resto del cortile, lasciandomi solo il cielo; e non ci perdo nel cambio. Faccio colazione con un tè caldo e due biscotti, guardando le nuvole rosa, finché – nel silenzio del sesto piano – non sento, dal corridoio, i passettini spediti del mio inquilino.
Livio è un omino compatto e insospettabilmente robusto. La sua faccia, che quando ha iniziato a farmi compagnia era pallida e tirata, sta lentamente riprendendo colore. Rimane sulla soglia della porta finché non lo saluto; poi mi scosto dalla scrivania scorrendo sulla sedia girevole, gli indico la sua alcova e lui ci s’infila con un libro in mano – se leggo bene, una monografia sul periodo ‘Ubaid. Mi avvicino di nuovo alla scrivania, sistemo le gambe in modo che non gli diano fastidio, e accendo il computer per iniziare la mia mattina di lavoro. La scrivania è chiusa sul lato che dà verso la porta, quindi per chi si affaccia alla mia porta o entra in studio, notare Livio sotto il mio tavolo è praticamente impossibile.
Mi metto a guardare un papiro particolarmente rognoso. L’immagine è ad alta risoluzione e le lettere le leggo bene, ma al rigo 15 non mi torna la grammatica della frase. Però sono riluttante a correggere il testo solo perché non lo capisco. Emergo da una prima fase di concentrazione rabbiosa verso le dieci e mezza del mattino, preso dal senso di colpa – del tutto inutile – per aver ignorato Livio che nel frattempo ha letto in silenzio.
– Stai comodo, Livio?
– Comodissimo, Giorgio, risponde lui senza alzare il naso dal libro.
– Vuoi un altro cuscino?
– Grazie, ne ho già tre.
– Vuoi che a pranzo ti vada a prendere uno di quei panini con la cotoletta che fanno dal pakistano?
– Per carità, io il fritto non lo devo nemmeno vedere. Ma tu pranzi alle dieci e mezza?
– No, dicevo dopo.
– Ah! Comunque no, grazie.
Sento gridare una voce dal corridoio:
– Con chi sei, Giorgio?
– Da solo, Elvira, rispondo.
Ma Elvira non si arrende facilmente. Eccola sulla soglia della mia porta, mentre si rimette a posto i capelli col fermaglio.
– Non c’è Bernacchi con te…?
– Non vedo Livio da settimane.
– Cazzo. Al telefono non risponde e l’ho cercato per tutto il palazzo.
– Vuoi lasciarmi detto, così se lo vedo…
– E che ti dico? C’è tutto, c’è, si sbraccia Elvira irritata. – Siamo col cappio al collo. Manca la sua parte di moduli per il PRIN che dobbiamo presentare a novembre. Ci doveva scrivere la sezione ‘Excellence’ per una MSCA di sezione che scade a settembre. Va bene, è stato male, ma ormai gli dovrebbe essere passato. Se si degna di comparire, digli che risponda al telefono e che è un coglione.
– Ma certo, Elvira.
Elvira si allontana e Livio mormora:
– Se la strega si occupasse di studiare e pubblicare tanto quanto si occupa di queste stronzate di raccolta fondi, forse almeno associato ci diventava.
– Zitto, che arriva gente.
Compunto, il bidello del sesto piano:
– Ci sono studenti che la cercano.
– Prego.
Due studenti, incerti.
– In realtà, professore, noi cercavamo il professor Bernacchi.
– Non lo vedo da settimane.
– Il professore ha terminato il corso un mese fa. Non risponde alle mail.
– Non vedo Bernacchi da settimane. Non ho informazioni da darvi per conto suo.
– Aveva messo un appello oggi, interviene il secondo studente.
– Voi sapete che non è stato bene.
– Sì, ma l’appello…
– Vi ha detto di dare l’esame con me?
Mi guardano turbati:
– No.
– Perché stiamo avendo questa conversazione?
– Magari lei sa dov’è il professore, ribatte seccato il primo.
– Non lo vedo da settimane. E tre.
– Ci scusi.
Escono. Sento Livio sibilare:
– Cazzo di bambini dell’asilo. Non sanno quanti sei piedi hanno tre anatre.
– Dio, sì. Ancora col moccio al naso.
– Odio la didattica.
– Anch’io, Livio.
Riusciamo a starcene tranquilli fino all’ora di pranzo. Evitiamo di chiacchierare, anche perché Livio quando studia non ama che lo interrompano, e io con quel papiro davvero non so dove andare a sbattere, non mi dà senso il testo. Frugo con angoscia su dizionari e repertori per cercare paralleli in letteratura. Mi concedo un’oretta per il pranzo, ritorno alla scrivania – Livio non si è mosso e non saluta. Sento appena il crepitio della matita sulle pagine che più lo interessano. Lascia brevi appunti nei margini. Verso le tre bussano alla porta aperta. Cinzia, a differenza di Elvira, non fa irruzione.
– Ciao Cinzia.
– Giorgio, disturbo?
– Assolutamente no. Un tè?
E indico il bollitore sul tavolino accanto, con cui a breve avrei fatto il tè per Livio.
– No, ti ringrazio. Mi posso accomodare?
– Ma certo.
Siede davanti alla mia scrivania. Se si fosse messa accanto a me, si sarebbe accorta di Livio. Così è impossibile che lo veda, ma può sentirlo se fa rumore. Con la coda dell’occhio vedo che Livio si è irrigidito.
– Dobbiamo parlare.
– Ti ascolto.
– Bernacchi.
– Uh.
– Tu sai che io sono la referente di sezione. Per assiriologia.
– Hai voglia se lo so.
– Mi rendo conto che non è affar tuo e mi dà fastidio darti noia. Ma so che tu e Bernacchi siete buoni amici. Non riusciamo a contattarlo da settimane.
– Nemmeno io.
– Siamo stati a casa sua. Le finestre sono chiuse e al campanello non risponde.
– Ci ho provato anch’io. Temo non sia proprio in casa.
– Sei preoccupato?
– Onestamente, no.
– Senza voler farmi i fatti suoi, ho saputo che è stato male.
– Un piccolo esaurimento, niente di che. Secondo me questa sparizione è il suo modo di farvi fronte. Avrà fatto fagotto e sarà partito per qualche buco nelle Alpi liguri. Adora i paesini.
– Però non si parte così, senza lasciar detto niente. C’è una marea d’impegni che ha preso e non sta mantenendo. Tu capisci che io rischio di dover emettere un richiamo ufficiale.
– Lo capisco, e non ho modo d’impedirtelo.
Cinzia si rigira le mani, piene di anelli.
– Tu sei sicuro di non sapere dove sia.
– Sicurissimo.
– E non siete in contatto.
– Non mi risponde da settimane.
– Ma non sei preoccupato.
– No. Si starà semplicemente rilassando da qualche parte dove nessuno lo cercherebbe. Tu molla la presa e vedrai che prima o poi te lo ritrovi in dipartimento come se niente fosse.
– Se succede, gli faccio un cazziatone che non ne esce vivo. Lo sai, questo.
– Lo immagino. E glielo dirò, se lo sento.
– Questo mi basta. Scusa il disturbo, Giorgio.
– Quando vuoi, Cinzia.
Cinzia si alza ed esce dalla porta. Livio continua a non respirare ancora per un minuto, poi molla il fiato e scioglie la tensione. Mi aspetto che commenti quanto ha appena sentito; ma tace. Io mi rimetto sul papiro di cui sopra, ché la settimana prossima cominciano i miei corsi, e sai tu quando avrò tempo per studiare ancora – forse a luglio. Il pomeriggio scolora nella sera e nelle prime tenebre della notte. Quando ormai il dipartimento è deserto, mi alzo e mi preparo per tornare a casa; Livio fa altrettanto, sbucando fuori da sotto la mia scrivania. Passiamo attraverso la porticina sul retro,da dove entriamo io la mattina e lui di nascosto; all’uscita ci separiamo, io verso casa mia e lui alla sua, dove entrerà di soppiatto e dormirà a finestre serrate, senza fare rumore.
– Comunque ci potresti andare davvero, in qualche paesino, sai? Invece di venire ogni giorno a nasconderti qui.
– Per carità. Mi verrebbe il doppio dell’ansia. E poi questo è un luogo che amo.
– Il luogo dove hai sbroccato, Livio?
– Ma mica per colpa sua. Per colpa vostra! Voialtri vampiri, tutti a volere un pezzo di me. Fai questo, aiutami a compilare quest’altro, scrivi quel progetto, vieni in commissione…
– Livio mio, se tu dicessi di no, ogni tanto…
– E come faccio? Quelli insistono. E io coglione a cercare di accontentare tutti. A forza di non fare né ricerca né insegnamento, mi è esploso il cervello.
Faccio un passo per allontanarmi, poi mi volto:
– Quando deciderai di tornare fra noi, posso aiutarti.
– A fare che?
– A compilare moduli. O a dire di no più spesso.
– Macché. Sono cose che devo saper fare io. E un giorno le farò, non ti credere.
– Ah sì?
– Sì. Un giorno sarò un quarantenne responsabile ed equilibrato, che sa dire di no quando deve, che s’impegna a fare solo quello che può far bene, che non tira pacchi e sa gestire il suo tempo e i suoi doveri istituzionali senza che gli venga una crisi di nervi.
– Un giorno.
– Esatto.
– Ma non è questo il giorno.
– Precisamente. Buona serata, Giorgio. Grazie sempre e a domani.
– Buonanotte, Livio.